"Scelta limitata": L'illusione di sistemi di controllo automatico - un omaggio a Philip Zimbardo
- Lorita Tinelli Psicologa
- 15 apr 2025
- Tempo di lettura: 19 min
di Janja Lalich
Questo saggio è stato scritto in onore del dott. Philip Zimbardo, morto il 14 ottobre 2024, all'età di 91 anni.
Il dottor. Zimbardo era meglio conosciuto per la sua teoria secondo cui fattori situazionali e sistemici possono portare la gente comune a commettere atti dannosi o immorali. La ricerca di Zimbardo si è concentrata sulla psicologia del male, che includeva studi sull'"effetto Lucifero", sulla de-individuazione e sull'effetto spettatore.
Il suo lavoro è stato particolarmente rilevante per la nostra comprensione della disumanizzazione e degli abusi sui prigionieri musulmani da parte dei soldati americani che erano guardie nella prigione di Abu Ghraib nel 2003 durante la “guerra al terrore” dell’America. Qui l’autrice illustra i modi in cui il proprio lavoro teorico è stato acquisito e intersecato con il lavoro di Zimbardo.
Il 17 maggio 1993 mi trovai davanti al dott. Zimbardo per la sua lezione di psicologia alla Stanford University di Palo Alto, in California. Le mie mani tremavano leggermente mentre mi preparavo a parlare per la prima volta pubblicamente della mia esperienza all'interno di un culto.
Il dottor. Zimbardo mi aveva invitato a condividere la mia storia, apparentemente comprendendo intuitivamente ciò che avrei studiato e articolato per i decenni successivi: ovvero che le persone intelligenti e istruite possono ritrovarsi a fare scelte apparentemente incomprensibili quando sono intrappolate in sistemi di dinamiche cultuali e controllo coercitivo.
Quel giorno segnò l’inizio del mio viaggio pubblico da sopravvissuta a studiosa, anche se non lo sapevo allora. Appena ho descritto il processo crescente attraverso cui la mia autonomia era stata limitata all’interno del culto politico cui ero appartenuta, ho visto nei volti degli studenti la stessa domanda che io stessa mi ponevo: “Come qualcuno potrebbe permettere che questo accada a se?” Era una domanda che alla fine mi avrebbe portato a sviluppare il concetto di "scelta limitata", un quadro teorico che avrebbe sia integrato che esteso il lavoro rivoluzionario di Zimbardo sul potere delle forze situazionali nel plasmare il comportamento umano.
Proprio come il famoso Esperimento della Prigione Stanford di Zimbardo ha rivelato gli studenti universitari ordinari potrebbero essere trasformati dai ruoli e dalle regole imposti loro, la mia ricerca, che è culminata nella mia teoria delle scelte limitate, avrebbe dimostrato poi come gli individui ad alto funzionamento possano essere intrappolati in una rete di vincoli che progressivamente restringono i loro processi di pensiero e la percezione delle opzioni disponibili. I parallelismi tra i nostri risultati, anche se raggiunti attraverso percorsi metodologici drasticamente diversi, illuminano una verità cruciale sulla natura umana: il contesto e il vincolo sono spesso più potenti del carattere.
In piedi in quell'auditorium, pieno di diverse centinaia di studenti, ero ancora lontana anni luce dalla comprensione completa delle implicazioni teoriche della mia esperienza. Ma il lavoro del dr. Zimbardo sulle forze situazionali aveva già fornito una base cruciale per comprendere come le persone altrimenti ragionevoli potessero impegnarsi in comportamenti che sembravano, a osservatori esterni, sia estremi che inspiegabili. La sua ricerca ha dimostrato che il comportamento individuale non può essere compreso in modo isolato dal suo contesto, un principio che sarebbe diventato centrale per la mia ricerca di dottorato e il concetto risultante di scelta limitata. All'inizio, Zimbardo era un contributo molto rispettato alla comprensione da parte della società, dei culti e delle loro dinamiche e del comportamento degli adepti.
Il concetto di scelta vincolata
Gli studenti che hanno partecipato allo Stanford Prison Experiment, come i membri del culto politico a cui ero appartenuta, non sono arrivati con disposizioni predeterminate verso l’autoritarismo o la sottomissione. Piuttosto si sono trovati a rispondere ad un ambiente sempre più restrittivo che ha modellato le loro percezioni, le scelte e, in definitiva, le loro azioni. Ciò che Zimbardo ha dimostrato in un lasso di tempo compresso nel suo esperimento, io l'ho vissuto per più di dieci anni: la graduale costruzione di un sistema chiuso di significato e comportamento che ha condotto a scelte precedentemente impensabili sembra non solo ragionevole ma necessario.
La teoria della scelta limitata è emersa dal mio bisogno di spiegare e chiarire come si verifica una tale trasformazione, non solo nei confini artificiali di un esperimento, ma anche nei contesti del mondo reale dei culti, di abusi domestici e di altri ambienti coercitivi. Mentre Zimbardo mostrava come la situazione potesse trionfare sulla disposizione, il mio lavoro avrebbe continuato a mappare i meccanismi specifici attraverso i quali queste situazioni creano sistemi di credenze trascendenti (estreme), sistemi di logiche auto-sigillanti e il restringimento sistematico di comportamenti accettabili e scelte percepite.
Quel giorno, in piedi davanti alla classe di Zimbardo, ha segnato il mio primo passo verso il ponte sul divario tra l’esperienza vissuta e la comprensione teorica. La sua volontà di mettere in campo la voce di un sopravvissuto – riconoscere che la testimonianza personale avrebbe potuto contribuire in modo significativo alla comprensione psicologica – ha esemplificato il tipo di studio di attraversamento dei confini che caratterizza entrambi i nostri approcci alla comprensione del comportamento umano sotto costrizione.
I parallelismi tra le scoperte di Zimbardo e la teoria della scelta limitata diventano particolarmente sorprendenti quando esaminiamo come entrambe le strutture illuminano il processo di trasformazione personale sotto vincoli sistematici. Nello Stanford Prison Experiment Zimbardo ha documentato come le “guardie” rappresentati da alcuni studenti abbiano gradualmente adottato comportamenti sempre più autoritari, mentre i “prigionieri” sono diventati progressivamente più passivi e dipendenti. Questa trasformazione non è avvenuta da un giorno all’altro. Piuttosto, si è verificato attraverso una serie di piccoli passi, ognuno dei quali si è costruito sugli ultimi, fino a quando i partecipanti non si sono trovati ad agire in modi che non avrebbero mai previsto.
Allo stesso modo, la teoria della scelta limitata spiega come gli individui in gruppi cultistici e coercitivi subiscono una trasformazione paragonabile attraverso quattro dimensioni interconnesse: il sistema di credenze trascendente, i sistemi di controllo, i sistemi di influenza e il sistema chiuso della logica, il tutto orchestrato dal cosiddetto leader carismatico (nota anche governante autoritario). Come le guardie e i prigionieri di Zimbardo, i membri della setta non abbandonano improvvisamente i loro valori e comportamenti precedenti. Invece, sperimentano un graduale rimodellamento della loro realtà attraverso queste quattro dimensioni, ognuno rafforzando le altre fino a quando le loro scelte non diventano sempre più limitate all’interno del quadro di significato del gruppo.
Zimbardo e la potenza situazionale
Ciò che Zimbardo ha dimostrato nel suo esperimento – che le aspettative di situazione e di ruolo potrebbero scavalcare le predisposizioni individuali – trova il suo parallelo nel mondo reale nella spiegazione della teoria delle scelte limitate di come i gruppi carismatici creano e mantengono la conformità.
La rigida gerarchia dell'esperimento carcerario, le regole arbitrarie e la deindividuazione sistematica rispecchiano i meccanismi attraverso i quali i gruppi cultuali stabiliscono e impongono i propri sistemi di controllo. In entrambi i casi, il potere non risiede nella forza diretta, ma nella creazione di un ambiente totalista che rimodella la percezione e il comportamento.
Tuttavia, la teoria delle scelte limitate si estende oltre l'attenzione situazionale di Zimbardo per esaminare più pienamente il modo in cui le persone partecipano attivamente al proprio vincolo. Attraverso l’interiorizzazione del sistema di credenze trascendenti e del sistema chiuso, i membri del gruppo diventano non solo soggetti di controllo esterno, ma manutentori attivi della propria realtà limitata e di quella degli altri. Questo aiuta a spiegare perché, a differenza dell’esperimento di Zimbardo che ha richiesto l’intervento esterno per finire, molte persone rimangono in gruppi coercitivi molto tempo dopo aver incontrato motivi per interrogarsi o andarsene.
Si consideri il caso di una guardia nell’esperimento di Zimbardo che aveva iniziato a creare elaborati conteggi ed esercizi per occupare il tempo dei prigionieri. A prima vista, questa potrebbe sembrare semplice crudeltà o una tendenza autoritaria intrinseca. Tuttavia, attraverso la lente della teoria della scelta limitata, possiamo comprendere questo comportamento come il prodotto di un'identità di ruolo interiorizzata che opera all'interno di un sistema di significato vincolato (una realtà delimitata). La guardia era arrivata a credere che mantenere un controllo rigoroso non fosse solo permesso, ma fosse necessario, proprio come i membri del culto che alla fine partecipavano a reclutare altri o ad applicare le regole di gruppo, credendo di star servendo uno scopo più alto.
La mia esperienza illustra questo parallelo vividamente. Come leader all’interno del Partito Democratico dei Lavoratori (il culto politico in cui ero stato), mi sono ritrovato a far rispettare misure disciplinari sempre più dure agli altri membri, credendo che queste azioni fossero necessarie per la rivoluzione per cui presumibilmente stavamo lavorando. Come le guardie di Zimbardo, che hanno razionalizzato il loro comportamento attraverso la lente del mantenimento dell’ordine carcerario, avevo interiorizzato un sistema di credenze che avrebbe trasformato le azioni oppressive in passi necessari verso un obiettivo trascendente.
Il potere di questi processi paralleli diventa ancora più chiaro quando esaminiamo come sia i prigionieri di Zimbardo che i membri del culto si adattano alle loro circostanze. Nell'esperimento di Stanford, i prigionieri che inizialmente si ribellarono alla fine divennero passivi e compiacenti, riferendosi persino a se stessi con il loro numero di prigione piuttosto che con i loro nomi. Allo stesso modo, nei gruppi settari, i membri accettano gradualmente controlli sempre più restrittivi e persino li difendono con gli altri. Il framework di scelta limitato spiega ciò che Zimbardo ha osservato: questi non sono semplicemente casi di sottomissione all’autorità, ma piuttosto esempi di come le persone si adattano e interiorizzano la logica del loro ambiente limitante.
Zimbardo ha ampliato la sua comprensione attraverso il suo esame dell'incidente della prigione di Abu Ghraib. Riconobbe lo sviluppo di simili dinamiche socio-psicologiche all’interno della prigione, rafforzando ulteriormente la sua comprensione della “psicologia del male”. Lo stesso Zimbardo ha dichiarato durante un'intervista del 2005:
"Quando metti insieme quella serie di orrende condizioni di lavoro e fattori esterni, crei un climo malvagio. Potresti inserire praticamente chiunque e otterrai lo stesso tipo di comportamento malvagio. Il Pentagono e i militari dicono che lo scandalo Abu Ghraib è il risultato di alcune mele cattive in un sistema altrimenti buono. Questa è l’analisi dispositiva. Lo psicologo sociale che è in me, e il consenso tra molti dei miei colleghi della psicologia sperimentale, dicono che è un'analisi sbagliata. Non sono le mele cattive, sono le botti cattive che corrompono le persone buone. Comprendere gli abusi in questa prigione irachena necessita di un’analisi delle forze situazionali e sistemiche che operano su quei soldati che lavorano nel turno di notte in quel “piccolo negozio di orrori”.
Ma forse il parallelo più sorprendente emerge all'indomani. Proprio come i partecipanti di Zimbardo hanno lottato in seguito per riconciliare il loro comportamento durante l’esperimento con le loro personalità normali, gli ex membri di sette spesso si impegnano a capire come hanno potuto partecipare ad azioni che ora sembrano chiaramente sbagliate, immorali o dannose. La teoria delle scelte vincolate fornisce un quadro cruciale per comprendere questo fenomeno, spiegando come le persone razionali possono fare scelte apparentemente irrazionali quando operano all'interno di un sistema chiuso di logica e significato, e sotto influenza e controllo.
Esempi nel mondo reale di scelta vincolata
I principi rivelati dall’esperimento di Zimbardo e dalla teoria della scelta limitata trovano una forte espressione nei regimi politici, in alcune società e in altre istituzioni totali.
In Corea del Nord, ad esempio, il controllo globale del governo sulle informazioni, combinato con l’ideologia trascendente dello stato di juche (autosufficienza), crea un sistema notevolmente simile a quello che osserviamo nei gruppi settari più piccoli. I cittadini non sono semplicemente costretti a forza: sono incorporati in un sistema di significato completo che modella la loro percezione della realtà e delle scelte disponibili.
In Cina, durante la Rivoluzione Culturale, abbiamo visto come la scelta limitata possa operare su vasta scala. I cittadini ordinari si sono ritrovati a partecipare a sessioni di lotta e a denunciare i membri della famiglia, non principalmente a causa della coercizione diretta, ma perché avevano interiorizzato un sistema di significato che ha fatto apparire queste azioni necessarie e giuste.
Il parallelo con l’esperimento di Zimbardo è sorprendente, entrambi illustrano la velocità con cui le persone possono adattarsi e far rispettare nuove norme sociali quando sono circondate da un ambiente totalizzante. Questo vale anche per altri stati totalitari e molti gruppi terroristici.
Anche il mondo aziendale ha dimostrato quanto la scelta limitata possa operare in contesti apparentemente legittimi. Il crollo di Enron è un esempio convincente. I dipendenti che hanno notato irregolarità finanziarie si sono trovati vincolati non solo da pressioni esterne, ma da una cultura aziendale interiorizzata che ha celebrato l’innovazione aggressiva e ha respinto i vincoli etici tradizionali. Come le guardie di Zimbardo, che hanno progressivamente attraversato i confini etici, i dipendenti di Enron hanno gradualmente accettato pratiche sempre più discutibili all’interno del loro sistema chiuso di logica aziendale.
Mentre serve legittimi scopi di difesa nazionale, impiega molti degli stessi meccanismi osservati sia nello Stanford Prison Experiment che nei gruppi settari: isolamento da precedenti contesti sociali, intensa pressione di gruppo, una missione trascendente e un sistema completo di regole e comportamenti. La differenza fondamentale non risiede nei meccanismi stessi, ma nel grado di trasparenza e responsabilità che circonda il loro uso.
La gestione dei casi di abusi sessuali da parte della Chiesa cattolica dimostra anche come la scelta limitata operi all’interno delle istituzioni consolidate. I funzionari della Chiesa, operando all’interno di un sistema chiuso che privilegia la conservazione istituzionale, hanno preso decisioni che ancora una volta appaiono incomprensibili dall’esterno ma hanno seguito una logica tragica all’interno del loro quadro limitato (chiuso). Come i partecipanti all’esperimento di Zimbardo che hanno perso di vista i confini etici al servizio dei loro ruoli, questi funzionari hanno gradualmente normalizzato le decisioni che proteggevano gli abusatori piuttosto che le vittime. Le istituzioni religiose, specialmente quelle che formano comunità affiatate, spesso soccombono alla tentazione di proteggere la loro posizione morale pubblica mantenendo segreti gli abusi sessuali interni. La Chiesa cattolica romana e i testimoni di Geova, tra gli altri, hanno gestito le notizie sugli abusi del clero come se il bene pubblico non fosse il loro problema. Non c’è dubbio che essi pongono il bene dell’organizzazione al di sopra dei bisogni del bambino o delle legittime richieste della società.
Collegare le informazioni di Zimbardo agli ingressi strutturali
Un aspetto insidioso della scelta limitata, come dimostrano sia il lavoro di Zimbardo che altri casi del mondo reale, è il modo in cui trasforma il significato stesso di resistenza e autonomia. A differenza della semplice coercizione, dove la scelta di resistere rimane psicologicamente chiara anche se fisicamente pericolosa, i sistemi di scelta vincolati ristrutturano il modo in cui gli individui concettualizzano la propria agenzia. Questa ristrutturazione si verifica in strati, rendendo la resistenza progressivamente più difficile da immaginare.
Considerate la mia esperienza e quelle degli altri nei culti politici: non ci vedevamo come arresi alla nostra autonomia; piuttosto, credevamo di esercitarla nella sua forma più alta sottomettendosi alle richieste del gruppo. Nel culto in cui ero, per esempio, questo era razionalizzato per mezzo del concetto di “libertà e necessità”. Le azioni immorali e dannose erano state normalizzate attraverso la nostra comprensione e accettazione della convinzione prevalente che il sacrificio della nostra libertà individuale fosse necessario per raggiungere i nostri obiettivi – così, ci siamo conformati a un’ideologia dominante che afferma che il fine giustifica i mezzi. Questo rispecchia come alcuni dei partecipanti all'esperimento di Zimbardo siano arrivati a vedere la loro crescente brutalità come una forma di responsabilità piuttosto che come abuso. Il sistema ridefinisce la resistenza stessa come una forma di debolezza o di tradimento, rendendo sospettato il concetto stesso di azione autonoma.
Ciò che rende questo particolarmente rilevante per comprendere la resilienza è il modo in cui spiega perché i concetti tradizionali di "forza del carattere" spesso non riescono a prevedere chi resisterà o chi si conformerà. Anche gli individui con forti valori preesistenti e alti livelli di istruzione si trovano vincolati non da barriere fisiche, ma da un quadro interiorizzato che fa apparire la resistenza non solo sbagliata, ma sia priva di significato che potenzialmente dannosa per se stessi per paura di punizione, espulsione o peggio. Ho visto questo modello ripetuto in più contesti – dai sopravvissuti agli abusi domestici che sono stati professionisti di successo agli informatori aziendali che hanno lottato per anni prima di parlare con attivisti ben intenzionati, che hanno ceduto a quello che a volte mi riferisco come “terrorismo ideologico”.
La teoria delle scelte limitate aiuta a spiegare perché la resistenza, quando emerge, spesso segue un modello di dissonanza cognitiva accumulata piuttosto che una realizzazione improvvisa. Come crepe che appaiono in un fondamento, piccole contraddizioni nella realtà delimitata cominciano ad accumularsi. Tuttavia, il sistema chiuso della logica ha tipicamente meccanismi incorporati per spiegare queste contraddizioni, proprio come i regimi totalitari sviluppano spiegazioni elaborate per i loro fallimenti che in realtà rafforzano piuttosto che minare le credenze fondamentali del sistema.
La comprensione della scelta limitata rivela perché gli approcci di intervento tradizionali spesso falliscono, dicendo a qualcuno “basta vai via” o “non riesci a vedere cosa sta succedendo?” Raramente funziona perché non si riesce ad affrontare la complessa rete di significato e costrizione (compresa la paura) che rende impossibili tali semplici azioni all’interno della realtà limitata della persona. Invece, un intervento efficace richiede di capire come la resilienza può essere coltivata pur riconoscendo i veri vincoli che le persone devono affrontare.
Strategie per promuovere la resilienza
La chiave sta in quello che io chiamo “mantenere il filo del dubbio”. Anche negli ambienti più totalizzati, gli individui spesso conservano piccole riserve private, proprio come alcuni dei partecipanti all'esperimento di Zimbardo, che hanno mantenuto preoccupazioni private anche mentre si conformavano pubblicamente. Questi fili del dubbio, per quanto lievi, possono diventare linee di vita per l’eventuale liberazione. Ho spesso fatto riferimento alla “metafora dello scaffale” nel descrivere questo fenomeno.
Quasi tutti i membri della setta hanno qualche dubbio o esitazione lungo la strada. Dato che non possono esprimere tali sentimenti, i dubbi vengono immagazzinati su uno scaffale nella parte posteriore della testa. L'ho osservato nei sopravvissuti che sono riusciti a preservare una piccola connessione con la loro identità pre-gruppo, spesso attraverso atti apparentemente insignificanti: tenere un diario nascosto, mantenere una relazione "non autorizzata" o trattenere un oggetto personale che li collegava al loro passato. E quando si verificano incidenti o richieste di troppo o “discutibili”, lo scaffale si rompe e la persona si rende conto che c’è qualcosa di sbagliato. Potrebbero non essere ancora in grado di agire su di esso; ma spesso è l'inizio dell'allontanamento dalla situazione coercitiva.
Pertanto, la resilienza non riguarda gli atti drammatici di resistenza, ma piuttosto riguarda il mantenimento di quelle minuscole fessure nella realtà delimitata. Si tratta di preservare quelle che io chiamo “tasche di pensiero autonomo” – quei momenti in cui le prospettive alternative possono emergere brevemente, anche se vengono rapidamente soppresse. Questa comprensione ha profonde implicazioni per gli approcci di intervento.
Approcci efficaci di intervento
1. Piuttosto che chiedere il riconoscimento immediato di abuso o controllo, l'intervento efficace consente alle persone di esplorare in sicurezza i loro dubbi senza minacciare immediatamente l'intero sistema di significato. Ciò potrebbe significare sostenere qualcuno nell'interrogare pratiche specifiche mentre si accetta temporaneamente il loro continuo impegno per le convinzioni fondamentali del gruppo.
2. Riconnettersi con l’Identità pre-gruppo: aiutare le persone a riconnettersi con aspetti della loro identità che hanno preceduto il loro coinvolgimento nell’ambiente totalistico. Non si tratta di cancellare la loro esperienza, ma di espandere il loro quadro di riferimento oltre il sistema limitato. Descrivo questo come fare qualcosa che si spera possa tirare le loro corde del cuore emotivo, risvegliando pensieri, sentimenti, ricordi che sono stati soppressi dai processi di indottrinamento del gruppo.
- 3. Affrontare i vincoli pratici: comprendere che la scelta limitata opera attraverso vincoli sia ideologici che pratici. Un intervento efficace richiede spesso di affrontare ostacoli concreti all’uscita – dipendenze finanziarie, paura dell’isolamento sociale, mancanza di abilità pratiche di vita – insieme a barriere psicologiche.
- 4. Building Alternative Support Systems: Riconoscere che gli ambienti totalitari diventano auto-rinforzanti in parte perché soddisfano i reali bisogni umani di appartenenza e significato. L'intervento deve includere aiutare le persone a trovare fonti alternative per queste esigenze.
Attraverso questa lente, la resilienza e il recupero non riguardano lo “spezzare le catene” in un momento drammatico, ma piuttosto riguardano l’espansione graduale dei confini della scelta. Si tratta di aiutare gli individui a riconoscere che ciò che sperimentano come libera scelta o il loro “libero arbitrio” può essere fortemente limitato (cioè la creazione dell’illusione di scelta), consentendo loro di rivendicare gradualmente la loro autonomia senza vergogna o sensi di colpa.
La comprensione della scelta limitata e dell'influenza situazionale fornisce informazioni cruciali per prevenire l'intrappolamento nei sistemi totalitari. La natura graduale del processo di intrappolamento – ciò che Zimbardo ha dimostrato potrebbe accadere in pochi giorni e ciò a cui ho assistito in mesi e anni – suggerisce che la prevenzione richiede lo sviluppo di ciò che potremmo chiamare “inoculazione cognitiva” contro la manipolazione sistematica.
Le strategie di prevenzione emergono dalla promozione della comprensione di come i sistemi di scelta limitati si stabiliscono in modo incrementale. In genere iniziano offrendo soluzioni a problemi reali o attraenti a nobili aspirazioni, sia che si tratti di creare un mondo migliore, trovare la realizzazione personale o servire uno scopo più alto. I passi iniziali spesso sembrano ragionevoli e persino lodevoli. Questo è ciò che rende la prevenzione particolarmente impegnativa: i segnali di allarme precoce possono apparire notevolmente simili ai cambiamenti positivi della vita o agli impegni significativi.
Tuttavia, comprendendo che le quattro dimensioni della scelta limitata – cioè il ruolo del leader autoritario, il sistema di credenze trascendente onnicomprensivo (cioè “La Verità”), i sistemi di controllo e i sistemi di influenza socio-psicologica – tendono a creare un sistema chiuso di logica e l’illusione della scelta, dobbiamo lavorare per educare gli altri e noi stessi ad essere attrezzati per identificare i primi segnali di avvertimento prima che i confini diventino troppo restrittivi.
Gli indicatori chiave includono:
Richieste di un impegno assoluto
Isolamento progressivo da prospettive esterne e mancanza di “controlli di realtà”
La riformulazione dei dati di realtà
Modelli di pensiero sempre più binario
La subordinazione delle esigenze personali alle richieste di gruppo
La conclusione
Ciò che il lavoro di Zimbardo e la mia ricerca dimostrano è che la vulnerabilità a questi sistemi chiusi e dannosi non riguarda la debolezza personale o la mancanza di intelligenza. Piuttosto, si tratta di suscettibilità umana ad essere attratti da obiettivi, scopi e significati, insieme a un potere crescente in modo incrementale all’interno di un ambiente totalitario che ha la capacità di rimodellare la percezione e il comportamento. Questa comprensione sposta gli sforzi di prevenzione dal semplice “avvertire le persone sui culti” all'aiutarli a riconoscere come qualsiasi ambiente – religioso, politico, aziendale o sociale – possa diventare totalitario (così come dannoso e sfruttatore) in determinate condizioni.
I parallelismi tra le scoperte di Zimbardo e la teoria della scelta limitata indicano una verità cruciale: la prevenzione più efficace non riguarda l’evitare gruppi o situazioni specifiche, ma piuttosto il mantenimento della consapevolezza di come le scelte possano diventare sistematicamente vincolate in qualsiasi contesto. Proprio come il lavoro di Zimbardo ha rivelato che le persone comuni potrebbero diventare perpetratori o vittime in condizioni specifiche, la teoria delle scelte delimitata illustra come gli individui intelligenti e ben intenzionati possano essere intrappolati in sistemi che progressivamente restringono la loro percezione e autonomia.
Entrambi i corpi di lavoro, anche se arrivati attraverso percorsi diversi – la sua sperimentazione controllata e la mia attraverso l’esperienza vissuta e la ricerca successiva – convergono su una visione fondamentale: il potere della situazione e il vincolo sistematico nel plasmare il comportamento umano è molto maggiore di quanto la maggior parte delle persone si renda conto. Questa comprensione, piuttosto che renderci pessimisti sulla natura umana, fornisce strumenti per la resistenza e la prevenzione. Riconoscendo come funziona la scelta limitata, possiamo mantenere meglio la nostra autonomia e aiutare gli altri a fare lo stesso.
Riflettendo su quel giorno nell'aula della Stanford University di Zimbardo nel 1993, vedo come i nostri rispettivi contributi alla comprensione del comportamento umano sotto costrizione abbiano creato un quadro più completo sia per la prevenzione che per l'intervento. L’eredità del nostro lavoro non sta solo nello spiegare come le persone diventano intrappolate, ma anche nell'illuminare percorsi verso il mantenimento e il recupero dell’autonomia umana di fronte a costrizioni sistematiche.
Mentre mi presentavo alle conferenze di sensibilizzazione del culto dalla fine degli anni '80, questa era la prima volta che parlavo a un pubblico che non identificava in modo auto-selettivo, ovvero in un modo o nell'altro, argomenti e questioni legate alle sette.
L'esperimento della prigione di Stanford è stato uno studio del 1971 ed ha dimostrato come le situazioni sociali possono influenzare il comportamento. È spesso usato nelle lezioni di psicologia per discutere l'etica della ricerca psicologica e la psicologia del male (vedi http://www.PrisonExp.org). Zimbardo lo descrisse come una “dimostrazione classica del potere delle situazioni sociali di distorcere le identità personali e i valori e la moralità a lungo amata, mentre gli studenti interiorizzavano identità proprie dei loro ruoli di prigionieri e guardie” (www.socialpsychology/zimbardo). Nonostante le recenti critiche all’esperimento, Zimbardo ha affermato che nessuna delle critiche ha fornito prove sostanziali che minano la conclusione principale, cioè l’importanza di capire come le forze sistemiche e situazionali possono influenzare il comportamento individuale, spesso senza la nostra consapevolezza (www.prisonexp.org / risposta).
3 Leggi, per esempip, P. Zimbardo, “What Messages Are Behind Today’s Cults?” APA Monitor, 14, May 1997; P. G. Zimbardo & M. R. Lieppe, The Psychology of Attitude Change and Social Influence (New York: McGraw-Hill, 1991); P. G. Zimbardo & S. A. Anderson, “Understanding Mind Control: Exotic and Mundane Mental Manipulations,” in Recovery from Cults, ed. M. Langone (New York: Norton, 1993), pp. 104-125; P. Zimbardo & C. F. Hartley, “Cults Go to High School: A Theoretical and Empirical Analysis of the Initial Stage in the Recruitment Process,” Cultic Studies Journal 2(1), 1985, pp. 91-147; Zimbardo, Philip., Mark, S., James, T., Alice, G., & Sharon, G. (1970). “Modifying the impact of persuasive communications with external distraction,” Journal of Personality and Social Psychology, 16(4), p. 669; Zimbardo, P. G. (1972). “The tactics and ethics of persuasion.” In Attitudes, conflict, and social change (pp. 81-99). Academic Press; Zimbardo, P.G. (2005). “Fictional concepts become operational realities in Jim Jones’ jungle experiment.” In A. Gleason, J. Goldsmith, & M. Nussbaum (Eds.), On nineteen eighty-four: Orwell and our future (pp.127-154). Princeton: Princeton University Press; Zimbardo, P. G. (2008). “Jonestown heroes.” In F. M. McGehee III (Ed.). The Jonestown Report 10; Zimbardo, P. G. (2020). “How Orwell’s 1984 has influenced Rev. Jim Jones to dominate and then destroy his followers: With extensions to current political leaders” Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 26(1), 4.
4 Janja Lalich, Bounded Choice: True Believers and Charismatic Cults (Berkeley: University of California Press, 2004).
5 See Robert Jay Lifton, Thought Reform and the Psychology of Totalism (New York: Harper, 1969).
6 See Philip Zimbardo, The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil (New York: Random House, 2007).
7 “You Can’t be a Sweet Cucumber in a Vinegar Barrel,” Edge: The Third Culture, 2005.
8 See Young Whan Kihl & Hong Nack Kim, North Korea: The Politics of Regime Survival (New York: Taylor & Francis, 2014); Paul French, North Korea: State of Paranoia (New York: Bloomsbury, 2015); Andrei Lankov, The Real North Korea: Life and Politics in the Failed Stalinist Utopia (New York: Oxford University Press, 2014).
9 Lifton, R. J. Thought Reform and the Psychology of Totalism (New York, Harper, 1969); Edgar Schein et. al, Coercive Persuasion: A Socio-psychological Analysis of the “Brainwashing” of American Civilian Prisoners by the Chinese Communists (New York: Norton, 1971; first publication The Massachusetts Institute of Technology, 1961).
10 An excellent source on this topic is Alesandra Stein’s Terror, Love and Brainwashing: Attachment in Cults and Totalitarian Systems (New York: Routledge, 2021).
11 See Chapter 7 in Dennis Tourish, The Dark Side of Transformational Leadership: A Critical Perspective (New York: Routledge, 2013).
12 Daniella Mestyanek Young, Uncultured (New York: St. Martin’s Press, 2022).
13 Marcia A. Hamilton, God vs. the Gavel: Religion and the Rule of Law (New York: Cambridge University Press, 2005, pp. 14-15).
References
Edge: The Third Culture. (2005). “You can’t be a sweet cucumber in a vinegar barrel.” Retrieved from http://www.edge.org/3rd_culture/zimbardo05/zimbardo05_index.html
French, P. (2015). North Korea: State of Paranoia. Bloomsbury.
Hamilton, M. (2005). God vs. the Gavel: Religion and the Rule of Law. Cambridge University Press, pp. 14-15.
Kihl, Y. W. & Kim, H. N. (2014). North Korea: The Politics of Regime Survival. Taylor & Francis.
Lankov, A. (2014). The Real North Korea ; Life and Politics in the Failed Stalinist Utopia. Oxford University Press.
Lalich, J. (2004). Bounded Choice: True Believers and Charismatic Cults. University of California Press.
Lifton, R. J. (1969). Thought Reform and the Psychology of Totalism. Harper.
Schein, E., with Schneier, I. & Barker, C. H. (1971). Coercive Persuasion: A Socio-psychological Analysis of the “Brainwashing” of American Civilian Prisoners by the Chinese Communists. Norton. (First publication: Center for International Studies, Massachusetts Institute of Technology, 1961).
Stanford Prison Experiment. Http://www.PrisonExp.org
Stein, A. (2021). Terror, Love and Brainwashing: Attachment in Cults and Totalitarian Systems. Routledge.
Tourish, D. (2013). The Dark Side of Transformational Leadership: A Critical Perspective, Chap. 7. Routledge.
Young, Daniella Mastyanek. (2022). Uncultured. St. Martin’s Press.
Zimbardo, P. (1997). “What Messages Are Behind Today’s Cults?” APA Monitor, 14, May.
Zimbardo, P. (2007). The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. Random House.
Zimbardo, P. & Hartley, C. F. (1985). “Cults Go to High School: A Theoretical and Empirical Analysis of the Initial Stage in the Recruitment Process.” Cultic Studies Journal 2 (1), pp. 91-147.
Zimbardo, P., Mark, S., James, T., Alice, G., & Sharon, G. (1970). “Modifying the Impact of Persuasive Communications with External Distraction.” Journal of Personality and Social Psychology, 16 (4), p. 669.
Zimbardo, P. G. (1972). “The Tactics and Ethics of Persuasion.” In Attitudes, Conflict, and Social Change. Academic Press, pp. 81-99.
Zimbardo, P. G. (2005). Fictional Concepts Become Operational Realities in Jim Jones’ Jungle Experiment. In Gleason, A., Goldsmith, J., & Nussbaum, M. (Eds.), On Nineteen Eighty-four: Orwell and Our Future. Princeton University Press, pp. 127-154.
Zimbardo, P. G. (2008). “Jonestown Heroes.” The Jonestown Report, vol. 10.
Zimbardo, P. G. (2020). “How Orwell’s 1984 Has Influenced Rev. Jim Jones to Dominate and Then Destroy His Followers: With Extensions to Current Political Leaders.” Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 26 (1), p. 4.
Zimbardo, P. G. & Andersen, S. A. (1993). Understanding Mind Control: Exotic and Mundane Mental Manipulations. In Langone, M. (Ed.), Recovery from Cults. Norton, pp. 104-125.
Zimbardo, P. G. & Lieppe, M. R. (1991). The Psychology of Attitude Change and Social Influence. McGraw-Hill.
Articolo pubblicato su ICSAToday dell'11 Aprile 2025
---------------------------------
Liberamente tradotto da Lorita Tinelli



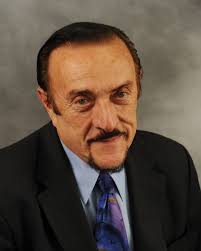



Commenti